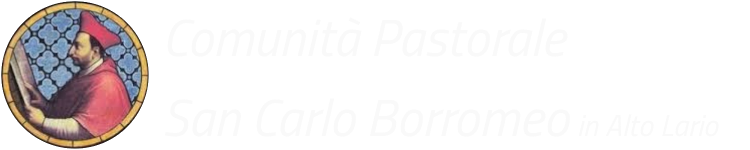Ultimo atto di una tragedia ormai annunciata. Ora si gioca il tutto e per tutto. E’ il round finale. L’ultimo miracolo, e poi via, verso Gerusalemme a dorso di un’asina. E non a caso l’ultimo miracolo raccontato da Matteo prima del racconto dell’ultima Pasqua è la guarigione di un cieco. Come a dire: solo con occhi nuovi si può vedere la verità di Dio e la verità dell’uomo. Gesù per questo è venuto e per questo è deciso ad andare fino alla fine: “Entrò poi nel tempio e scacciò tutti quelli che vi trovò a comprare e a vendere; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe”. (Mt 21,12).
L’Antico Testamento, si chiude con il libro di Malachia e con la promessa che il Signore sarebbe venuto nel suo tempio. Il Signore è venuto: si è fatto uomo. E al compimento della sua esistenza terrena entra nel tempio. A fare cosa? Diceva Malachia: “arriverà come il fuoco che brucia tutto, arriverà come la lisciva, come la candeggina che sbianca tutto” (Mal 3,2-3): quindi arriva con qualcosa di tremendo per distruggere e corrodere tutto. La venuta di Gesù nel tempio distrugge e corrode l’idea che abbiamo di Dio, e una religiosità e un modo di pregare che non portano più a Dio.
L’immagine di Dio che tutti più o meno abbiamo è quella del salmo 28 che il liturgista ha scelto per questa domenica: “Date al Signore gloria e potenza…”, “la voce del Signore è forza…”, “il Signore è seduto sull’oceano del cielo…”. Se noi abbiamo l’immagine di un Dio potente ci rivolgiamo a Lui per partecipare del suo potere: per implorarlo, cioè, di risolvere i nostri problemi.
Se abbiamo l’immagine di un Dio violento, cerchiamo di placarlo con i nostri sacrifici. In ogni caso il rapporto che ci lega a Lui è quello di una sudditanza paurosa, dove al centro non c’è l’incontro con Dio, la consolazione e la gioia che vengono da Lui; bensì il timore, e la serie delle nostre pratiche ben codificate volte a placare un Dio sempre pronto a punire e a castigare. Gesù, entrando in Gerusalemme con l’asinello, in modo mite, stravolge questa immagine di Dio, distrugge il tempio dove al centro ci sono le pratiche dell’uomo; distrugge l’idea di Dio come la pensiamo noi. A quel Dio a immagine dell’uomo che ci siamo costruiti, sostituisce in modo mite, ma deciso, se stesso: l’uomo a immagine di Dio, l’uomo libero. Il nuovo e vero tempio di Dio sarà Lui, l’uomo libero. Il legame nuovo che lega l’uomo a Dio è la relazione del Figlio, che sa amare i fratelli.
Dopo aver rovesciato tavoli e sedie, Gesù spiega così il suo gesto. E disse loro: “La Scrittura dice: La mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate una spelonca di ladri” (Mt 21,13).
La mia casa è casa di preghiera (citazione di Isaia 56,7). Nel vangelo di Matteo la preghiera è qualcosa di molto chiaro: è il Padre nostro. E Gesù dice che ha a che fare con la casa: è, dunque, sentimento, familiarità, spontaneità, lacrime e sogni. Pregare è come voler bene: quando si ama, si dice alla persona amata: vieni a vivere nella mia casa. La mia casa è la tua casa. La preghiera è dire a Dio: vieni a vivere con me. E’ metter su casa con Dio. Una casa colma di canti e di grida. Infatti ecco il vangelo: i fanciulli nel tempio si mettono a gridare di gioia: osanna! (Mt 21,15). Tutto questo ci fa pensare alla liturgia come a qualcosa di caldo; un contesto in cui ci si riconosce, dove ciascuno vive un’appartenenza; in cui ciò che accade è una relazione coinvolgente, che prende dentro la vita con le sue gioie e le sue fatiche; che fa gustare la bellezza dell’essere parte del popolo di Dio, e alimenta il desiderio di esserci sempre e di coinvolgere altri in questa appartenenza vitale.
Le nostre liturgie da tempo si sono allontanate da tutto questo. La pandemia, con le sue restrizioni, ha solo reso evidente quanto già da anni sta accadendo. Si avverte sempre meno l’appartenenza alla comunità, la familiarità con gli altri presenti, la responsabilità condivisa perché la qualità della celebrazione racconti la gioia di essere insieme alla presenza del Signore. Sono sempre meno i preti, ma sono anche sempre meno coloro che si sentono parte viva della comunità e responsabili della sua vitalità. E così tante delle nostre celebrazioni risultano sbiadite, senza una comunità che le anima: nessun lettore, nessun cantore… o sempre i soliti pochi, che se non ci sono quelli… e tanti spettatori, che si aspettano di trovare tutto pronto, di vivere la loro preghiera personale, di assolvere il precetto…, ma che non si lasciano coinvolgere, e non vivono una vera appartenenza.
Da dove ripartire? Sicuramente dal mettere a tema la questione, con quello stile sinodale di confronto franco e cordiale che il papa auspica diventi sempre più il modo di confrontarsi nelle comunità cristiane e nella Chiesa tutta, smettendo di guardare con nostalgia al passato, e osando scelte di novità, gravide del desiderio di tornare alla freschezza del vangelo e ad una viva e calda relazione con il Padre, dentro relazioni fraterne di comunità.
don Andrea